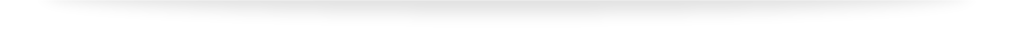Nonostante una normativa recente (artt. 27-28 del D.Lgs 81/08 che sostituisce la “vecchia” L. 626/94 sulla sicurezza) imponga alle aziende specifiche prescrizioni in termina di tutela di rischi di stress psico-sociale, le aziende, soprattutto di medio e piccola dimensione, sono ancora lontane dal recepire culturalmente l’attenzione all’ergonomia dell’ambiente psico-fisico, sociale e relazionale che caratterizza il micro-cosmo lavorativo. In un momento in cui il lavoro è un fattore di alta centralità nella vita degli individui, in cui entrano fattori di incertezza legati non solo all’attuale restrizione dei mercati, ma soprattutto al ripensamento collettivo sugli assetti sociali in cui il ruolo del lavoro è il medium fra ricerca di sicurezza e di libertà e autodeterminazione, molte aziende rimangono saldamente ancorate a dimensioni tecnologiche, di pratiche e abilità specifiche, di “saper fare” piuttosto che “saper essere”.
I decisori scelgono, in pratica, di investire sulle abilità e le conoscenze piuttosto che la crescita personale, preferendo poi affrontare i notevoli costi dell’insoddisfazione lavorativa, misconosciuti perché spalmati sul lungo periodo. Certamente fra insoddisfazione e stress vi è un rapporto ambiguo, ma è indubbio che le due dimensioni si autoalimentano, creando non solo turnover e malattie legate ai sintomi dello stress (l’O.M.S. stima che il 70% delle assenze per malattia siano causate da fattori etiologicamente legati al disagio psicologico) ma anche notevoli errori, ritiro dalle responsabilità, rallentamento dei ritmi di lavoro, avaria ai macchinari ed attrezzature.
Eppure l’orientamento delle istituzioni internazionali, prima fra tutte l’Unione Europea che ha emanato un accordo quadro che ha ispirato l’attuale Testo Unico sulla Sicurezza, è chiaramente tracciato: si discute sui criteri di standardizzazione per includere, fra i fattori di qualità per la relativa certificazione, anche quelli relativi all’ambiente psicosociale. Ciò nonostante, le stesse associazioni di categoria, in qualche caso, arrivano a consigliare i loro associati di non adeguarsi alla normativa (a dire il vero, poco chiara su alcuni aspetti): ciò non solo è grave perché espone le aziende al rischio di pesanti sanzioni da parte dello SPISAL e a richieste di risarcimento danni nel caso i lavoratori riescano a dimostrare che un quadro patologico origina nello stress lavorativo, ma soprattutto è sintomatico del blocco culturale e del ripiegamento su antiche culture, quasi di ispirazione tayloristica, che ancora pervadono le aziende e le organizzazioni imprenditoriali.
I vari autori che si sono occupati di stress da lavoro (da Karasek a Maslach, da Cohen a Spielberger solo per citare i più noti) sono concordi nel non tracciare linee di confine invalicabili fra l’ambiente di lavoro e il cosmo relazionale, sociale e gruppale dei singoli lavoratori, poiché non vi è confine fra i vari setting di vita e non può esserci confine fra l’azienda e il mondo esterno. I fatti dei singoli sono fatti dell’organizzazione, poiché quello che accade al suo interno non può rimanere confinato fra le sue mura, e ciò che accade all’esterno non può non riguardare le aziende che sono sempre più coinvolte in fattori di responsabilità sociale, non come aspetti prescrittivi, ma come motivi irrinunciabili di successo.
Gli stakeholder oggi non sono più solo gli azionisti, le banche, clienti e fornitori, ma l’intero ambiente relazionale che si estende dalla singola postazione di lavoro fino all’organizzazione sociale. Come recitava Brofenbrenner, non esistono fatti non psicologici e non esistono zone di confine (come invece ipotizzava Lewin nella sua Teoria di Campo) fra i vari ambienti di vita. Lo stress è quindi un fatto organizzativo, non individuale: modifica gli esiti del lavoro, causa danni e costi di bilancio, annebbia la percezione di equità e si insinua nelle procedure, rallentandole, disorientando il problem solving e la presa di decisione, favorendo il ritiro dalle responsabilità (il fenomeno del social loafing).
Eppure, da un’indagine in corso di realizzazione da un’associazione di artigiani del Nordest, emerge che i lavoratori non solo non sono stati informati sulle prescrizioni della normativa ma lamentano, da parte dei manager e dei decisori, la scarsa attenzione ai rischi psico-sociali, come la conflittualità, l’incertezza, la confusione di ruoli, la scarsa auto-determinatezza, l’anomia del futuro… che continuano ad essere considerati come fatti privati dei lavoratori, che entrano fra le mura aziendali come un aspetto patologico e devono essere rimossi solo quando non garantiscono l’efficienza dei processi, e sui quali non è conveniente e tantomeno “etico” intervenire in fase preventiva.
La prevenzione, al contrario, è proprio l’aspetto preponderante dell’Accordo Quadro Europeo dell’8 ottobre 2004, non in termini di anticipazione di una “fase della medicina” (come piacerebbe esprimersi il prof. Spaltro), ma come elemento di cambiamento e di cultura, come orientamento al “saper essere” non solo per il lavoratore nell’azienda, ma anche per l’azienda nella società e, in altri termini, come elemento di successo nel mercato.