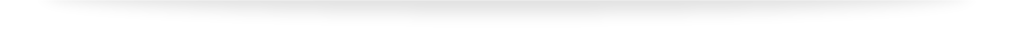La mancanza di una stretta rete di relazioni tra tessuto imprenditoriale e industriale – uno degli aspetti negativi del modello italiano dell’innovazione – è tanto più preoccupante se si pensa che, causa la sempre maggiore specializzazione delle competenze e la difficoltà nel reperire risorse finanziarie adeguate, il processo di innovazione tecnologica è sempre meno frequentemente il risultato di attività di ricerca e sviluppo realizzate e controllate all’interno di una sola impresa.
Anzi, lo scenario più probabile propone una situazione in cui sarà più importante saper gestire la rete delle competenze esterne all’azienda piuttosto che potenziare solo le competenze interne.
Grazie ad un’indagine promossa da AREA Science Park, è stato possibile realizzare un’analisi del legame tra innovazione, sviluppo locale e imprenditorialità, e dei sistemi di valutazione dei Sistemi Innovativi.
Secondo gli autori della ricerca, gli aspetti che sembrano favorire l’innovazione sono così schematizzabili:
- fluidità nella diffusione della conoscenza
- capacità di trasformare la conoscenza in idea imprenditoriale
- “variabili di sistema”: capitale umano, sistema economico e reti di comunicazioni tra operatori pubblici e privati
- concentrazione geografica: vicinanza tra imprese, laboratori di ricerca e Università
Nel rispetto di quanto suggerito da questa ricerca (soprattutto i punti 1 e 2), una strada che si sta cercando di sviluppare in Italia per favorire la crescita innovativa è l’incentivazione degli spin-off della ricerca: parliamo in pratica di realtà aziendali, indipendenti ed autonome, nate da persone o competenze fuoriuscite da ambienti accademici o comunque di ricerca.
Per favorire questo fenomeno, il Ministero dello Sviluppo Economico ha promosso l’imprenditorialità innovativa sulla base della legge 388/00 art. 106 e grazie al programma FIxO (Formazione & Innovazione per l’Occupazione) ed enti di ricerca – quali ad esempio ENEA e CNR – promuovono varie iniziative a favore degli spin-off da ricerca.
È interessante notare come ci siano diversi casi di aziende affermate e leader in vari settori nate come spin-off dalla ricerca:
- Hoechst: oggi Sanofi Aventis, è stata fondata da Heinrich Caro (della Basf) e due altri allievi di von Liebig
- Siemens, Philips, Schlumberger: sono alcuni esempi di aziende nate all’inizio del ventesimo secolo grazie alle conoscenze di scienziati e ricercatori (nel caso particolare, Werner von Siemens, Gerard Philips e Conrad Schlumberger)
- Hewlett e Packard: la loro società nacque in seguito alla spinta del prof. Frederick Terman verso due suoi allievi, Hewlett e Packard appunto, ad avviare un’iniziativa imprenditoriale.
In Italia le imprese nate da spin-off sono caratterizzate dall’essere di piccole dimensioni, e dall’essere molto diversificate sul fronte dei settori industriali in cui operano.
Circa la metà delle imprese sono nate per svolgere pura attività produttiva compresa la commercializzazione dei prodotti, mentre pressappoco un terzo delle imprese svolge attività di servizio e solo una piccola parte si occupa di ricerca su contratto.
Un’analisi diffusa dalla Camera di Commercio di Milano sottolinea come la principale motivazione alla nascita di un’impresa da spin-off accademico, infatti, sia legata all’identificazione di una precisa opportunità di mercato, e che quasi la metà delle aziende siano state fondate grazie alla collaborazione tra ricercatori e imprenditori.
Secondo molti esperti, analizzando i settori a maggiore sviluppo modiale le istituzioni del nostro Paese devono porre maggiore attenzione sulle possibilità rappresentate da questo strumento d’innovazione, anche prendendo a modello realtà quali il MIT o l’Università di Twente.
I punti 3 e 4 sopra menzionati sembrano poi essere l’anima ispiratrice di un’altra iniziativa da anni viva nel nostro Paese: il parco tecnologico (consulta l’offerta nazionale, per ulteriori approfondimenti).
Il parco tecnologico/scientifico è, sinteticamente, una area industriale attrezzata riservata a persone che intendano realizzare o sviluppare idee a carattere fortemente sperimentale.
Il tema dei Parchi Scientifici e Tecnologici appare nel dibattito italiano verso gli anni Ottanta, sulla ruota delle esperienze americana e giapponese che avevano sottolineato il rapporto positivo tra parco e sviluppo dell’economia locale. La struttura dei parchi, era originariamente basata sull’idea di iniziative logistiche e immobiliari per favorire la localizzazione integrata di imprese ad alto contenuto innovativo e la creazione di “economie di agglomerazione”, puntando molto sulla condivisione di risorse, esperienze e del know-how. Un’accezione particolare che è stata data in Italia ai Parchi Scientifici e Tecnologici è stata quella di volano di sviluppo per le aree svantaggiate.
Il Programma Tecnopolis Novus Ortus nasce infatti a Bari nel 1984, proprio in questa ottica. In seguito, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, si dà inizio ad operazioni sperimentali in alcune aree del Paese adattando l’idea alla realtà italiana. In modo particolare si apre di più ad azioni di carattere privato e si cerca di allargare l’area geografica di riferimento, perdendo l’unità di luogo e realizzando un sistema di “rete”.
Un esempio di questa idea è La Città della Scienza la cui mission è: «promuovere e realizzare iniziative in grado di generare valore per l’intero sistema locale, nel quadro delle attività d’indirizzo del Socio Unico regionale, delle politiche nazionali e comunitarie e delle indicazioni emergenti dal dialogo con gli stakeholder».
Sono inoltre degni di nota alcune iniziative volte alla diffusione e alla valorizzazione delle idee innovative, in questo caso parliamo di iniziative spesso volte a “premiare” idee ed proposte che abbiano già mostrato le proprie potenzialità.
Un primo esempio sono le “Start Cup” promosse da Enti di ricerca e Università quali ad esempio la Federico II di Napoli – la cui iniziativa nata nel 2003 conta al suo attivo 800 partecipanti, 250 idee d’impresa, 4 spin-off e 12 imprese sul mercato – e il premio PNI (Premio Nazionale per l’Innovazione), che ha chiamato a raccolta i vincitori delle Start Cup italiane. Il PNI ha favorito la nascita di 120 spin-off e che ha permesso a 200 imprese di essere oggi sul mercato.
Altro esempio è il “Premio Imprese x l’Innovazione” promosso da Confindustria e APQI (Associazione Premio Qualità Italia), il cui obiettivo dichiarato è «far conoscere e diffondere modelli organizzativi e strategici specificatamente orientati alla crescita attraverso l’innovazione».
Indubbiamente il tessuto imprenditoriale del nostro Paese trae forza da una capacità di innovazione molto spiccata che però, nonostante quanto esposto in queste pagine, sembra ancora non ben supportata da una linea strutturata e programmatica, senza contare il peso di una cultura imprenditoriale e di una politica diffusa che devono far propria l’idea di collaborare con modalità basate più sull’incentivo che sull’assistenzialismo