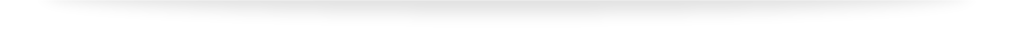Aspetti fiscali, poteri di vigilanza, obblighi contrattuali dei gestori delle piattaforme, regole a garanzia della concorrenza, tutela della privacy, linee guida per la diffusione di buone pratiche: sono i capitoli fondamentali previsti dalla proposta di legge sulla sharing economy in discussione alla Camera, su cui il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, ha fornito una serie di spunti di analisi in audizione davanti alle commissioni riunione Trasporti e Attività produttive, rilevando criticità in particolare sulle misure fiscali e sull’applicazione dell’IVA. La norma sulla:
«Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione dei beni e servizi e disposizioni per la promozione dell’economia di condivisione» ha l’obiettivo di regolamentare la sharing economy, che Orlandi definisce «un nuovo modello economico e culturale fondato sullo scambio alla pari di beni e servizi (mercato peer to peer), in alternativa all’acquisto degli stessi come tipicamente accade nell’economia tradizionale».
=> Linee guida UE sulla Sharing Economy
In pratica, prosegue Orlandi:
«I meccanismi di funzionamento dell’economia condivisa consentono a soggetti che non operano in maniera professionale sul mercato, di utilizzare i propri beni privati e prestare servizi a fini economici e lucrativi. Gli strumenti della tecnologia e i social network hanno contribuito in maniera determinante alla diffusione del fenomeno e ne hanno ampliato notevolmente le potenzialità, soprattutto perché hanno esteso e facilitato l’accesso ai servizi e ai beni oggetto di condivisione».
I settori maggiormente interessanti: crowdfunding, trasporti, servizi di scambio di beni di consumo, turismo. La rapida diffusione della sharing economy pone all’attenzione del legislatore, sia europeo sia nazionale, la necessità di una regolamentazione che garantisca la diffusione del nuovo modello di business non in contrasto con mercato e regole della concorrenza, a tutela sia degli operatori professionali sia degli utenti.
=> Sharing economy: la proposta italiana
La Commissione Europea (comunicazione 356/2016) ha predisposto linee guida in materia di requisiti di accesso al mercato, regimi di responsabilità, tutela degli utenti, tutela dei lavoratori, fiscalità. L’obiettivo della proposta di legge italiana, chiarisce Orlandi:
«Consiste nel garantire equità e trasparenza, soprattutto in termini di regole e di fiscalità, tra i soggetti che operano in tale ambito e gli operatori economici tradizionali e, al contempo, nel tutelare i consumatori soprattutto per gli aspetti connessi alla sicurezza, alla salute, alla privacy e alla trasparenza delle condizioni contrattuali».
L’articolo 2 della legge definisce la sharing economy (economia della condivisione) come:
«Economia generata dall’allocazione ottimizzata e condivisa delle risorse di spazio, tempo, beni e servizi tramite piattaforme digitali», i cui gestori «agiscono da abilitatori mettendo in contatto gli utenti e possono offrire servizi di valore aggiunto», e precisa che «i beni che generano valore per la piattaforma appartengono agli utenti», e tra questi ultimi e il gestore «non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato». Sono escluse dalla definizione le piattaforme che operano intermediazione in favore di operatori professionali iscritti al registro delle imprese.
La vigilanza spetta all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM), che esprime anche un parere vincolante sul documento di politica aziendale con le condizioni contrattuali verso i clienti di cui devono obbligatoriamente dotarsi i gestori delle piattaforme. le eventuali transazioni in denaro avvengono solo tramite sistemi di pagamento elettronico e con modalità di registrazione univoche per tutti gli utenti (bisogna inserire generalità, dati anagrafici, residenza, codice fiscale), per evitare che si creino profili falsi o non riconducibili al titolare.
È poi prevista una delega al governo per misure annuali che garantiscano il corretto funzionamento e sviluppo del mercato della sharing economy, mentre ministero dello Sviluppo economico di concerto con quello per Semplificazioni e Pubblica amministrazione dovrà prevedere linee guida per gli enti locali con l’obiettivo di diffondere buone pratiche ed eventuali sperimentazioni. Infine, la norma prevede specifiche misure per garantire privacy e riservatezza degli utenti, e la disciplina di controlli e sanzioni per le piattaforme.
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate si sofferma particolarmente sugli aspetti fiscali, a cui è dedicato l’articolo 5 della legge, che distingue fra operatori professionali e non professionali, che segnano i redditi derivanti dalle attività di sharing economy in una specifica sezione della dichiarazione dei redditi, con relativa tassazione agevolata: nel dettaglio, per redditi derivanti da attività di sharing economy fino a 10mila euro, si applica un’aliquota agevolata del 10%. Se invece il reddito è superiore, si applica la normale tassazione, cumulandolo con gli altri eventuali redditi da lavoro dipendente e autonomo.
Perché la fiscalità funzioni con efficacia, sono previste misure di tracciabilità, potenziate dal fatto che sono direttamente le piattaforme ad agire come sostituti d’imposta e da obblighi di comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate. Sono invece ancora da definire una serie di aspetti che Orlandi sottolinea:
- non viene fornita una disciplina di dettaglio su modalità di determinazione del reddito: fra le altre cose, non è specificato quale sia il corretto criterio di cumulo per i redditi sopra i 10mila euro (per esempio, non è specificato se si applica comunque l’aliquota fissa fino ai 10mila euro e solo per la parte eccedente il diverso trattamento fiscale);
- non è chiaro se la soglia dei 10mila euro oltre a determinare un diverso trattamento fiscale costituisca anche il discrimine fra attività professionale e attività occasionale;
- da definire impatto sui contribuenti che applicano il regime dei minimi;
- chiarimenti sull’esclusione dall’applicazione della legge di piattaforme di sharing economy che non prevedono versamenti di denaro (come blablacar, o scambiocasa.com).
Orlandi fa poi una serie di osservazioni tecniche relative agli obblighi, per le piattaforme gestite da società estere, di avere una stabile organizzazione in Italia, piuttosto che sulle problematiche relative alla corretta applicazione dell’IVA. In conclusione, Orlandi ritiene che la proposta di legge risponda a:
«Obiettivi di interesse generale, quali la trasparenza, l’equità fiscale, la tutela dei consumatori, il rispetto della concorrenza, mentre presenta aspetti da chiarire che si concentrano in particolare sulla fiscalità, il cui campo di applicazione «appare circoscritto al solo reddito prodotto attraverso le piattaforme digitali» dagli utenti non professionali, senza fra l’altro intervenire sul regime IVA da applicare sulle relative operazioni. In pratica, si tratta di un primo passo, che però richiederà ulteriori interventi, «vista la complessità del fenomeno e le diverse variabili da considerare» relative a un settore che «ha enormi potenzialità per la competitività e la crescita del Paese».
Fonte: Audizione dell’Agenzia delle Entrate in Commissione alla Camera.