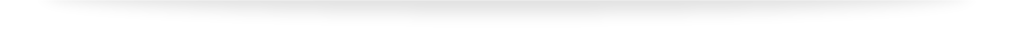di Davide Maria Testa, avvocato, esperto in diritto del lavoro, relazioni industriali e riorganizzazioni aziendali
Un messaggio di posta elettronica è un documento informatico, anche se non firmato digitalmente. E, a meno che non ne vengano contestate l’autenticità o il contenuto, può avere valore probatorio.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con una sentenza, la n. 14046 del 21 maggio 2024, su una vicenda molto particolare che vede sullo sfondo l’ambito di estensione di una copertura assicurativa contro furti, stipulata da un imprenditore (trasportatore) con una compagnia assicurativa, per il tramite di un broker.
Email con valore probatorio: il caso analizzato dalla Cassazione
Nel caso di specie, il trasportatore ha subito il furto di due motrici e di un rimorchio contenente un carico di medicinali, a lui affidati per il relativo trasporto. A seguito del furto della merce, il mittente, ovvero l’azienda che ha affidato al trasportatore la spedizione dei medicinali, ha chiesto di essere risarcito per la perdita del carico e,
dunque, il vettore ha chiesto al proprio assicuratore di essere manlevato rispetto a tale pretesa.
Tuttavia, la compagnia assicurativa ha rifiutato di pagare l’indennizzo, opponendo che “il contratto di assicurazione escludeva dalla copertura i danni derivanti dal furto di medicinali”.
Dunque, il trasportatore ha convenuto in giudizio sia la compagnia assicurativa sia il broker intermediario, chiedendone la condanna, in solido o in via alternativa, al pagamento dell’indennizzo.
A sostegno della propria domanda, il trasportatore ha dedotto che «l’estensione della copertura al rischio di furto di medicinali doveva ritenersi operante per effetto di uno scambio di email tra il broker e un funzionario» della compagnia assicurativa.
In subordine, ha dedotto altresì che «la mancata estensione della copertura doveva ascriversi a responsabilità del broker, per non avere saputo offrire all’assicurato un contratto adatto alle sue esigenze assicurative».
La prima sentenza e il ricorso in appello
Il Tribunale di Milano ha ritenuto che «il rischio avveratosi fosse coperto dalla polizza per effetto delle modifiche ad esse apportate su richiesta del broker, richiesta dimostrata dallo scambio di messaggi di posta elettronica tra il broker e il funzionario» della compagnia assicurativa.
La sentenza è stata oggetto d’appello: appello principale da parte del trasportatore, al fine di sentir condannare anche il broker in qualità di corresponsabile, «a pagare la differenza fra il danno da esso effettivamente subito e quanto riconosciutogli dalla compagnia assicurativa in forza della sentenza di primo grado.
E appello incidentale da parte della compagnia assicurativa, al fine di vedersi sollevata da ogni responsabilità, in assenza di stipula dell’estensione della polizza assicurativa al trasporto dei medicinali, «dato che il contratto doveva essere provato per iscritto e che le mail prodotte in atti non integravano una prova scritta, in quanto non potevano considerarsi sottoscritte».
La Corte d’Appello ha ritenuto di accogliere il gravame incidentale. A fondamento della propria decisione, per quel che riguarda la tematica di analisi, la Corte ha osservato che:
- il gravame incidentale della compagnia assicurativa «era da ritenersi fondato, in quanto, dovendo il contratto di assicurazione essere provato per iscritto ai sensi dell’articolo 1888 c.c., nella specie l’estensione della polizza (modificative di un’espressa previsione contrattuale, e cioè l’art. 15 lett. C che escludeva il trasporto dei medicinali) non è stato oggetto di un documento scritto per cosi dire “tradizionale”, cioè un’appendice contrattuale firmata dal contraente (o suo mandatario) e dalla società assicurativa, bensì di uno scambio di e-mail fra il broker e certo sign. – della compagnia assicurativa»;
- si era trattato di uno scambio di semplici, ordinarie e-mail e non di PEC: la mail ordinaria «ha il valore di una fotocopia, rectius di una riproduzione meccanica, e fa piena prova, ex art. 2712 c.c., solo se non contestata»;
- «in caso di contratto da provarsi per iscritto lo scambio di mail non potrebbe quindi ricoprire lo stesso valore di una scrittura privata, dato che non è detto che a spedire le mail siano stati davvero i titolari dell’account e non un’altra persona»;
- «non poteva quindi ritenersi che l’asserita estensione assicurativa sia stata provata per iscritto».
A fronte di tale decisione, il trasportatore ha proposto ricorso per Cassazione.
L’iter argomentativo della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto, nel merito, il ricorso proposto dal trasportatore. Il trasportatore ha sostanzialmente lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2712 c.c., anche in relazione degli articoli 2702 e 1888 dello stesso codice civile, nonché la «omessa pronuncia sui motivi che avrebbero potuto portare ad affermare il riconoscimento dell’efficacia di prova scritta e quindi di idoneità alla modifica estensiva della polizza assicurativa della e-mail inviata dal funzionario (della compagnia assicurativa), anche in quanto scrittura non disconosciuta (dalla compagnia assicurativa)».
Ed in effetti, richiamando la normativa codicistica, il ricorrente deduce che un messaggio di posta elettronica “ordinaria” costituisce ai sensi dell’art. 2712 del codice civile un “documento informatico” che, se non disconosciuto, forma piena prova dei fatti in esso rappresentati e «poiché la provenienza della e-mail di estensione della copertura non era stata contestata, la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere soddisfatto il requisito della forma scritta».
I Giudici della Cassazione individuano sin da subito due questioni di diritto poste alla loro attenzione: quali condizioni un atto debba soddisfare perché possa ritenersi “scritto” per i fini di cui all’articolo 1888 c.c.; e l’efficacia probatoria del messaggio di posta elettronica privo di firma elettronica qualificata o digitale. Trattasi di due questioni disciplinate da norme modificate più volte tra l’epoca in cui si svolsero i fatti (novembre 2009) e quella della decisione d’appello (gennaio 2021).
Dal momento che le norme sull’efficacia dei mezzi di prova hanno natura sostanziale (e non processuale), la modifica di tali previsioni non sfugge al generale principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. c.c.). Pertanto, «il motivo di ricorso andrà dunque vagliato in base al quadro normative vigente alla data del novembre 2009».
Nel merito, a parer dei Giudici, il motivo di ricorso è fondato. Infatti, la Corte d’Appello ha escluso di possedere una prova scritta dell’estensione della copertura assicurativa sulla base dei seguenti assunti:
- l’assicurato è in possesso di una e-mail proveniente dal dominio della compagnia assicurativa ma non sottoscritta con firma digitale;
- non v’è certezza che essa sia stata spedita dal titolare del relativo account invece che da un terzo;
- tale incertezza è stata rafforzata dal fatto che la compagnia assicurativa «ha contestato la mancanza delle sottoscrizioni necessarie ex art. 1888 c.c.».
=> Come fare la firma digitale: rilascio e utilizzo
Dunque, sulla base del rilievo per cui l’e-mail in questione non era munita di sottoscrizione con firma digitale, i giudici d’appello ne hanno escluso in toto sia qualsiasi rilievo probatorio, sia la natura di atto scritto.
Tuttavia, a parere della Cassazione, questa valutazione non è conforme a diritto per due motivi: «sia per quanto attiene la questione (di diritto sostanziale) della forma che un atto deve possedere per soddisfare ii requisito dello scritto, di cui all’art. 1888 c.c.». E «sia per quanto attiene il problema (di diritto processuale) delle condizioni da osservare affinché una prova documentale possa essere utilizzata in giudizio».
La tematica relativa ai requisiti di atto scritto ai fini dell’art. 1888 c.c., a parer dei giudici di Cassazione avrebbe dovuto essere risolta «muovendo dalla premessa che il messaggio di posta elettronica è un documento informatico».
«Le condizioni richieste dalla legge affinché un documento informatico potesse ritenersi uno “scritto” idoneo a soddisfare il requisito della forma ad probationem del contratto assicurativo, erano stabilite all’epoca dei fatti di causa (novembre 2009) dagli articoli 20 e 21 del d. lgs. 82/2005 (nel testo applicabile ratione temporis, cioè successivo al d. lgs. 4 aprile 2006, n. 159, ed anteriore alle modifiche di cui al d. lgs. 30 dicembre 2010, n. 235).
Tali norme distinguevano i documenti informatici sottoscritti con firma elettronica “semplice” da quelli sottoscritti con firma elettronica “qualificata o digitale”.
Il caso di specie riguarda un documento con firma elettronica semplice. L’articolo 20, comma 1-bis, d. lgs. 82/05 stabiliva: «l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di [qualità,] sicurezza, integrità ed immodificabilità».
Nel corso del giudizio d’appello è intervenuta l’abrogazione del sostantivo “qualità”, (indicato appositamente tra parentesi quadre) che, però, a parer della Cassazione, “non muta la portata precettiva della norma”.
Ed è proprio qui che risiede il nodo della decisione. Infatti, come hanno osservato i giudici di Cassazione, la Corte d’appello non avrebbe dovuto «limitarsi a negare tout court che un messaggio di posta elettronica con firma elettronica semplice potesse soddisfare il requisito della forma scritta» ma, al contrario, avrebbe dovuto approfondire l’esame sull’esistenza o meno delle “caratteristiche oggettive” menzionate nell’articolo 20 del dlgs 82/2005.
Ma la Cassazione non si limita ad affermare ciò e fornisce altresì le indicazioni pratiche su come l’approfondimento dovrebbe essere condotto.
«Le suddette caratteristiche di “qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità”, poiché debbono essere oggettive andranno desunte dal corpus mechanicum a disposizione del giudicante: e quindi – in particolare – dal formato del file in cui il messaggio di posta è stato salvato; dalle proprietà di esso; dalla sintassi adottata; dalla grafica. Questa valutazione andrà condotta alla luce del consolidato principio per cui la prova scritta del contratto di assicurazione può essere desunta anche da documenti diversi dalla polizza, purché provenienti dalle parti e da questi sottoscritti, dai quali sia possibile desumere l’esistenza ed il contenuto del patto».
Una volta fotografati i requisiti di legge affinché un messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma semplice possa soddisfare il requisito della forma scritta, la Cassazione ha spostato il proprio focus d’analisi sui requisiti di legge affinché un documento informatico possa essere utilizzato come prova in giudizio.
Conclusioni della Corte di Cassazione
A conclusione delle proprie riflessioni, la Cassazione ha, dunque, affermato che «i princìpi desumibili dalla legge sono dunque pochi e semplici, e possono così riassumersi:
- il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell’art. 2712 c.c.;
- se non ne sono contestati la provenienza o il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate;
- se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità».