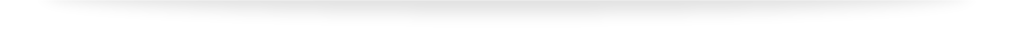Le aziende italiane sono molto poco flessibili: lo dice uno studio dell’Osservatorio Diversity Management dell’Sda Bocconi sullo stato dell’arte della flessibilità nella pratica delle imprese (prassi relative a flessibilità organizzativa, “lavoro liquido” o consumerizzazione che dir si voglia).
Il progresso tecnologico, così come i cambiamenti culturali e sociali, permettono e anzi favoriscono modelli di lavoro che, in realtà, le aziende praticano poco e soprattutto non premiano.
La ricerca dimostra come ci sia un gap fra le forme di flessibilità attuate in azienda e quelle richieste dai lavoratori. Le prime sostanzialmente riguardano part-time e flessibilità in entrata e in uscita, mentre i secondi vorrebbero applicare nuove modalità di lavoro, soprattutto legate a tecnologia, appartenenza culturali o geografiche. Ma raramente i lavoratori incontrano questa possibilità in azienda.
Lavoro da remoto o in sede?
Un punto importante riguarda la presenza in ufficio: nell’epoca del cloud computing, degli smartphone e dei tablet, di Internet, la presenza fisica in ufficio continua ad essere considerata molto importante dalle aziende. Un webinar del novembre scorso organizzata dalla Sda Bocconi sul diversity management ha proposto un sondaggio dal quale è emerso che per la stragrande maggioranza del campione, l’87%, la presenza in ufficio magari anche per tante ore al giorno conta molto o addirittura in modo fondamentale per lo sviluppo della carriera.
Lo studio dell’osservatorio fa emergere quella che viene chiamata “sindrome del controllo” da parte delle aziende, che in genere considerano molto più produttivo chi trascorre tante ore al lavoro e meno chi invece privilegia forme di flessibilità.
L’orario di lavoro continua a essere misurato su base settimanale e a rimanere rigidamente ancorato al luogo fisico dell’impresa così come regolamentato dai contratti di lavoro, spesso si timbra il cartellino in ingresso e uscita.
Lavoro flessibile
Per contro, le forme di lavoro flessibile praticate, come ad esempio il part-time, non solo vedono comunque l’Italia be al di sotto dei valori europei, ma spesso si traducono in una minor possibilità di fare carriera.
Per riassumere, il presenzialismo è un valore molto radicato nelle aziende italiane, mentre chi adotta forme di flessibilità viene considerato meno produttivo.
Ma, si chiedono Simona Cuomo e Adele Mapelli, coordinatrici dell’Osservatorio sul diversity management della Sda Bocconi, siamo sicuri che il modello ancorato alla presenza fisica «sia ancora il più efficace?». E che «stare con il fiato sul collo dei propri collaboratori sia l’unico modo per ottenere risultati?». O ancora «che escludere a priori dallo sviluppo di carriera un lavoratore part-time sia una buona scelta?».
Flessibilità e performance
L’Osservatorio sta realizzando un progetto di ricerca chiamato Le diverse facce della flessibilità, con l’obiettivo di «analizzare la relazione tra adozione di forme di flessibilità e performance individuale», verificare «in quale misura chi è flessibile è escluso dai percorsi di sviluppo e di riconoscimento organizzativo», e individuare «best practise organizzative nelle imprese per cercare di diffondere una cultura del tempo determinata dal raggiungimento dell’obiettivo e non dalla necessità di rendersi visibili agli occhi del capo».
Comunque, le ricerche che l’Osservatorio svolge da anni sulla situazione nelle imprese italiane, nonchè la letteratura internazionali in proposito, tendono a dimostrare che modelli di diversity appropriati hanno un triplice effetto positivo, in termini di vantaggi economici (anche grazie a risparmi su turn over, assenteismo, spese legali), di immagine per l’azienda, di produttività.