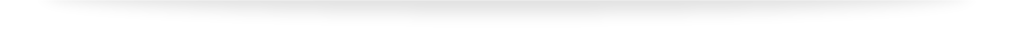Grazie al Superbonus, nel biennio 2021-2022 sono stati investiti 16,5 miliardi di euro nelle abitazioni, e il contributo alla crescita del PIL dovuto agli investimenti in costruzioni residenziali è stato del 2%, di cui l’1% grazie alla maxi detrazione del 110%. Considerando anche il Bonus Facciate al 90%, nel triennio 2020-2022 i crediti maturati hanno generato effetti complessivi pari a circa 90 miliardi di euro.
Un forte impulso all’economia reale, nonostante l’impatto sui conti pubblici e le violazioni emerse negli anni di investimento massiccio nel comparto edile, grazie al traino dei maxi-bonus fiscali.
I dati sono quelli forniti nelle scorse settimane dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) in audizione sul Decreto Cessioni Superbonus, che dopo il voto degli emendamenti in Commissione di avvia alla discussione in Aula, dove si auspicano ulteriori correttivi rispetto a quelli già approvati nei giorni scorsi.
L’analisi dell’UPB
Le agevolazioni edilizie, introdotte come incentivo alle ristrutturazioni edilizie e all’efficientamento energetico, sono state prorogate e potenziate nel corso degli anni, passando da 2,6 a 9,2 miliardi di euro annuali dal 2008 al 2019. A partire dalla legge di bilancio 2020, alcune sono state rese equivalenti a una forma diretta di spesa per contrastare gli effetti della pandemia, e il Superbonus ha ridotto la regressività delle agevolazioni edilizie, consentendo una maggiore fruizione da parte delle aree meno ricche del Paese. Tuttavia, la distribuzione territoriale delle detrazioni evidenzia ancora una profonda divisione per livelli di ricchezza, con una maggiore incidenza nel Nord-Est del Paese, e oltre il 60% delle detrazioni è stato usufruito da contribuenti residenti nelle regioni del Nord.
Bonus edilizi: un po’ di storia
Le agevolazioni edilizie sono state originariamente concepite come misure temporanee per incentivare la ristrutturazione degli edifici attraverso detrazioni dall’IRPEF con aliquota relativamente contenuta (inizialmente al 41% e successivamente al 36%). Lo scopo principale era quello di sostenere il settore delle costruzioni e di promuovere l’emersione. Nel corso degli anni, queste agevolazioni sono state prorogate e potenziate, con un aumento dell’aliquota e del tetto di spesa.
Dal 2007, le agevolazioni sono state estese anche all’efficientamento energetico. Nel periodo compreso tra il 2008 e il 2019, ovvero prima della pandemia, l’utilizzo delle detrazioni è aumentato notevolmente, passando da 2,6 a 9,2 miliardi di euro all’anno, con un incremento effettivo del 350% in undici anni. Le modifiche apportate hanno portato a un cambiamento nella distribuzione delle agevolazioni rispetto ai bonus edilizi iniziali.
A partire dalla legge di bilancio 2020, sono state gradualmente introdotte disposizioni che hanno trasformato alcune di queste detrazioni in forme dirette di finanziamento. L’intero costo dei lavori di efficienza energetica e miglioramento sismico degli edifici è stato assunto dallo Stato, eliminando il conflitto di interesse tra fornitori e acquirenti riguardo al costo degli interventi: inizia la fase Superbonus.
A stretto giro, inoltre, per contrastare gli effetti negativi della pandemia e permettere l’accesso alle agevolazioni anche ai redditi bassi, sono state notevolmente ampliate le possibilità di usufruire di queste agevolazioni tramite lo sconto in fattura e il credito d’imposta cedibile a terzi.
Il boom del Superbonus
In generale, la spesa per agevolazioni nel settore edilizio, comprese le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, le facciate, ecc., è destinata a superare i 110 miliardi di euro. Il Superbonus rappresenta la maggioranza della spesa, con detrazioni e crediti d’imposta che ammontano a oltre 75 miliardi di euro. Secondo i dati dell’Enea, le detrazioni annuali (e i relativi crediti potenziali) per i lavori conclusi entro il 2022 sono stimate intorno ai 12 miliardi di euro, ovvero circa 4,8 volte quelle del 2021. Se si considerano anche gli investimenti non ancora conclusi entro il 2022 e quelli asseverati fino a febbraio 2023, potrebbero generarsi ulteriori crediti potenziali fino a 6 miliardi di euro all’anno a partire dal 2024.
L’analisi sui Comuni sembra indicare che la detrazione del 110% abbia avuto un impatto meno regressivo rispetto agli incentivi precedentemente erogati. Ciò ha consentito una maggiore fruizione delle agevolazioni da parte delle aree meno ricche del Paese, in particolare del Mezzogiorno, che ha visto più che raddoppiare la propria quota di risorse.
Tuttavia, la distribuzione territoriale mostra che vi è una maggiore incidenza del ricorso alla misura nel Nord-Est del Paese, con un investimento medio per abitante di circa 1.379 euro, superiore della media nazionale (1.160 euro) del 19%. Questo è dovuto alla più alta intensità di fruizione della misura (+32% rispetto alla media nazionale) piuttosto che a un costo medio dell’investimento più elevato, che risulta infatti del 10% inferiore alla media nazionale.
Il divario nel Paese
La geografia delle agevolazioni edilizie rivela un divario significativo tra le diverse fasce di reddito del Paese. Più del 50% dell’ammontare totale delle agevolazioni è stato usufruito da un decimo dei contribuenti più ricchi.
Rispetto alle detrazioni per la ristrutturazione edilizia, quelle per gli interventi di riqualificazione energetica, che offrono le detrazioni più alte, sembrano essere leggermente più concentrate tra i contribuenti più ricchi. Questo si riflette anche nella distribuzione geografica delle agevolazioni, dove il 60% delle detrazioni è stato usufruito dai contribuenti residenti nelle regioni del Nord, che sono quelle più ricche. In particolare, il Nord-Est rappresenta il 28,3% del totale, mentre il Nord-Ovest il 37,7%. Le regioni del Centro seguono con il 19,4%, mentre il Sud e le Isole rappresentano rispettivamente solo il 10,3% e il 4,4%.
Questi dati suggeriscono che la distribuzione territoriale delle agevolazioni edilizie e per la riqualificazione energetica riflette la disuguaglianza nella distribuzione del reddito tra i beneficiari. Le regioni più ricche del Nord del Paese sono quelle che maggiormente traggono vantaggio da questi incentivi.