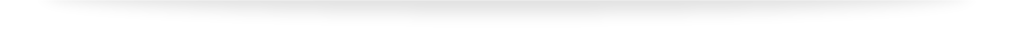Quale bottino frutterà agli italiani la trattativa per il nuovo governo che nascerà entro qualche settimana? In termini di tasse, lavoro, cosiddetto (perché si tratta di altro) reddito di cittadinanza, strategie di medio-lungo periodo come il Def e il rispetto del rapporto deficit/Pil al 3% e dei vincoli europei, sterilizzazione dell’Iva, posizioni a Bruxelles?
Le probabilità che una buona parte delle scoppiettanti promesse elettorali possa trasformarsi in realtà diminuiscono all’aumentare dell’artificialità delle maggioranze che usciranno dalle consultazioni al Quirinale.
Ma anche in quella che per primi abbiamo chiamato Frankenstein – cioè un possibile sodalizio giallo-verde fra Movimento 5 Stelle e Lega che così mostruoso potrebbe non essere, vista la vicinanza su alcuni punti e l’affinità degli elettorati – il bilancio potrebbe risultare assai magro.
Mentre Forza Italia (ma anche leghisti “istituzionali” come Roberto Maroni) sbarrano la strada a un accordo fra i due gruppi parlamentari in ottica esecutivo, Matteo Salvini ripete invece da giorni che “ci sono punti in comune” e che “nulla è impossibile”. La volontà di tenere le porte aperte a un governo di breve durata, senza Di Maio premier, che imposti Def e legge di bilancio, riformi la regole del gioco per le elezioni e conduca a un nuovo voto entro un anno al massimo potrebbe essere nelle corde del leader di via Bellerio. Al prezzo tuttavia di far saltare la già inesistente coalizione di centrodestra (ma può anche darsi che, all’ultimo, perfino Berlusconi si lasci convincere e se non lui molti dei suoi pronti a saltare sul carroccio vincente).
Ma quali sono questi punti in comune, in particolare sotto il profilo fiscale, industriale e previdenziale, fra le due liste che hanno vinto il 4 marzo? Conviene partire da questi per rendersi conto di come sarà impossibile che vengano portati a termine in una mini-legislatura di semiscopo, cioè ciò che comincia a intravedersi dalle finestrelle del torrino del Colle.
La legge Fornero, varata con l’Italia a un passo dalla bancarotta a fine 2011, ha alzato l’età minima per andare in pensione di vecchiaia prevedendo revisioni periodiche, e ha introdotto quella “anticipata” al verificarsi di una certa soglia di anni di contribuzione (quest’anno sono 42 anni e 10 mesi per gli uomini e uno in meno per le donne). Salvini ne ha fatto una sua battaglia assoluta e intende puntare all’abolizione nonostante sarebbe un’impresa anche per una maggioranza molto compatta ribaltare il sistema pensionistico italiano, negando per giunta una progressività inevitabile per l’invecchiamento della popolazione. In ogni caso, per farlo occorre un sostegno granitico. I 5 Stelle sul tema hanno posizioni più moderate. Intendono superare la riforma pensionistica lavorando soprattutto sul secondo fronte, quello dell’anticipata, abbassandolo a quota 41. Potrebbe essere una strada percorribile oltre che la più sensata.
C’è poi il Jobs Act, sul quale si è scatenata una ridda di cifre e interpretazioni e che, al netto della sopravvivenza dei contratti attivati nel 2015, ha fruttato 700mila nuovi posti di lavoro. Nelle imprese con oltre 15 dipendenti (che sono pure aumentate in numero) ha ridotto le possibilità di reintegra in caso di licenziamento illegittimo, scegliendo la strada dei risarcimenti ed estendendo così la mancata tutela dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori anche alle aziende più grandi (quelle sotto i 15 già non ne godevano).
Tirandosi dietro, a cascata, tutto il traino degli ammortizzatori sociali, dei sussidi di disoccupazione e il solito vuoto delle politiche attive. Già su questo fronte si aprono contraddizioni significative fra i due possibili pretendenti: se dal M5S si pensa di poterlo reintrodurre, Salvini le ha sostenute un po’ tutte, spiegando una volta che “non tutto il Jobs Act va cancellato”. Su ogni cosa aleggia ovviamente la pressione delle associazioni degli industriali.
Esistono poi altri punti, come una frenata sulla contestazione all’Europa pur in un approccio profondamente critico – nessuno dei due parla ormai da tempo di uscita dall’Euro o dall’Ue – la possibilità di sforare il 3% del rapporto deficit/Pil (ma nessuno parla mai delle procedure d’infrazione) pure in questo caso con toni diversi, il taglio dei vitalizi in realtà in gran parte già tagliati, la necessità di sterilizzare l’aumento dell’Iva previsto dalle clausole di salvaguardia che ci portiamo dietro dalla crisi del 2011 (costerà 12 miliardi di euro) e le proposte per la spending review nel Documento di economia e finanza da varare in primavera, antipasto della legge di bilancio.
Il rapporto rischia di interrompersi qui. Il reddito di cittadinanza dovrà per esempio cambiare pelle e perfino nome, se vorrà trovare l’appoggio della Lega. Anche se in fondo già non è ciò che promette di essere: non un compenso dato a tutti i cittadini a prescindere da occupazione e reddito ma un’integrazione rispetto alla soglia minima di povertà che somiglia alla miriade di strumenti di welfare sperimentati in tutta Europa da decenni.
Il tema è l’asticella, collocata troppo in alto senza diversificare la platea dei beneficiari, e l’assenza del motore essenziale di una simile iniziativa. Vale a dire una rete efficiente di centri per l’impiego che impieghi davvero altre persone oltre chi ci lavora.
Stesso discorso per la flat tax salviniana al 15%, a dire il vero un po’ inabissatasi negli ultimi tempi, che arricchirebbe i ricchi per colpire chi ha di meno mortificando, a meno di complicati bilanciamenti che tradirebbero la volontà di fare piazza pulita di detrazioni e altri strumenti, la progressività prevista dalla Costituzione.
Di Maio ci è tornato poco prima delle elezioni: “Penso che la flat tax sia incostituzionale”. In altri casi aveva parlato di “bufala” spiegando che “applicarla sarebbe pura follia” e puntando invece a una riduzione progressiva delle aliquote Irpef. Ma in fondo prima delle elezioni di promesse se ne sono fatte molte, di impegni se ne sono presi di ogni tipo. Anche quello di far dimettere il neosenatore Emanuele Dessì, quello che abita a Frascati, vicino Roma, in una casa popolare da 7 euro e si bullava in rete di picchiare i romeni, puntualmente accettato nel gruppo di palazzo Madama.
Non ci sarebbe dunque da stupirsi. Ma è impossibile che ai grillini possa andare giù una manovra come la “pace fiscale” inserita nel programma della Lega, una specie di rottamazione hard delle cartelle esattoriali. Insomma, un maxicondono in piena regola e in totale tradizione italica.
Questa la sostanza a cui ci sarebbero da aggiungere l’accordo sulla legge elettorale, la sintonia totale sull’abolizione dell’obbligo dei vaccini e in fondo anche sulla gestione dell’immigrazione, fronte che divide i pentastellati – la cui base, lo dimostrano i flussi, ha sottratto molto anche all’elettorato di centrosinistra – ma sul quale non si è esitato a speculare nel corso del 2017, dai “taxi del Mediterraneo” in poi.
In ogni caso, margini per un governo con pochi punti ce ne sarebbero. Appare chiaro, tuttavia, come i roboanti programmi elettorali siano destinati al congelamento per almeno un anno o, nella migliore delle ipotesi (per chi ha votato quei partiti, ovviamente) a concretizzarsi in versioni profondamente ridimensionate e (s)corrette.