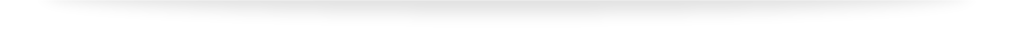Il termine “Glocale” deriva dalla fusione di “Globale” e “Locale” e definisce una strategia di approccio al mercato sviluppatasi a seguito di tre fenomeni:
- il crollo dei costi di trasporto delle merci (dai primi anni ’80)
- l’industrializzazione dei paesi emergenti del sud est asiatico (dalla metà degli anni ’80)
- la nascita di Internet (dalla fine degli anni ’90)
Un approccio al mercato di tipo Glocale rappresenta, ad oggi, una delle poche vie in grado di garantire la sopravvivenza di un gran numero di piccole e medie imprese. In particolare, la “glocalizzazione” rappresenta l’unica strada che garantisce competitività alle PMI delle aree deboli dei paesi industrializzati e cioè, nel caso a noi più vicino, è una scelta obbligata per le imprese del Mezzogiorno d’Italia.
Per capire cos’è la “dimensione glocale” bisogna considerare lo scenario in cui le nuove tecnologie e il crollo dei costi di trasporto, permettono a chiunque di commercializzare a livello globale piccole produzioni ad elevata tipicità locale. È una sorta di globalizzazione al contrario: mentre la globalizzazione uniforma consumi e stili di vita, la glocalizzazione consente la valorizzazione di piccole produzioni ad elevata tipicità locale in territori remoti. Con globalizzazione e glocalizzazione, in definitiva, la dimensione nazionale scompare a favore della dimensione globale e di quella regionale.
La glocalizzazione diventa importante per le piccole e medie imprese delle aree deboli dell’Occidente (il cosiddetto “Sud del Nord”), che sono schiacciate da due forze che sembrano inarrestabili. Nelle produzioni a basso contenuto tecnologico, devono affrontare la concorrenza insostenibile dei paesi di nuova industrializzazione (Sud-Est asiatico in primis), mentre nelle produzioni ad alto contenuto tecnologico la sfida viene delle aree forti dell’Occidente (Nord Italia, Europa Centro-Settentrionale, East Coast e West Coast statunitensi, Giappone, etc.).
Le ragioni sono, tutto sommato, semplici. Nell’ultimo decennio, ha avuto culmine un processo iniziato già negli anni ’80: l’abbattimento delle barriere geografiche nel mercato. Il crollo dei costi di trasporto delle merci, iniziato proprio negli anni ’80, ha avvicinato i paesi poveri a quelli ricchi. Per sfruttare questa situazione, la WTO ha istituito le cosiddette Aree di Libero Scambio, piccole zone ubicate prevalentemente nei paesi del Sud Est asiatico, nelle quali l’insediamento di attività produttive era soggetto a un regime fiscale molto favorevole. Le imprese occidentali hanno cominciato il processo di delocalizzazione che ha portato allo spostamento del baricentro dell’economia occidentale dal settore secondario al terziario e al quaternario, a beneficio dei paesi del Sud Est asiatico.
Negli anni ’90, questo fenomeno ha perso gran parte degli aspetti positivi che lo avevano caratterizzato all’inizio ed ha portato al verificarsi di situazioni condannabili come quelle denunciate da Naomi Klein nel suo best-seller “No Logo”, ma questa è un’altra storia. In questa sede ciò che ci interessa è che, a livello mondiale, si sono progressivamente creati due poli: quello delle aree forti dei paesi occidentali, caratterizzato da produzione e politiche di commercializzazione ad alto contenuto tecnologico; quello delle aree di nuova industrializzazione in Asia e Centro America caratterizzato dalla presenza di una forte industria manifatturiera che sfrutta i risparmi sul costo del lavoro (e spesso della sicurezza sul lavoro). L’introduzione della proprietà privata in Cina, e il consegeunte ingresso di un paese con un miliardo e mezzo di abitanti in questo schema, ha fatto poi precipitare gli eventi.
In questo scenario, parrebbe che le aree deboli dei paesi forti (come il nostro Mezzogiorno, appunto) non abbiano speranza: non hanno le risorse (e le infrastrutture) per competere in tecnologia con i grandi poli mondiali, non hanno la possibilità di competere sul prezzo con i paesi in via di sviluppo. La terza via è rappresentata, appunto, dalla glocalizzazione. Gran parte del “Sud del Nord” (e in particolare il nostro Mezzogiorno) è caratterizzato dalla presenza di miriadi di piccole produzioni tipiche di alta qualità che, fino ad oggi, hanno servito il solo mercato locale. Pensiamo al calzaturiero, al tessile, alle ceramiche, al settore alimentare nel Sud ma anche ai tanti distretti del centro-nord Italia formati, spesso, da microimprese con produzioni quasi artigianali di qualità senza pari a livello globale.
Fino ad oggi, soprattutto al Sud, queste aziende si sono limitate a vendere nel loro mercato geografico di riferimento: la produzione è sempre stata limitata e la domanda del mercato locale era in grado di assorbirla tutta. Le piccole aziende olivicole o tessili del mercato pugliese, quelle delle ceramiche o del pomodoro campane non si sono mai preoccupate di cercare nuovi mercati di sbocco. Ma oggi, la concorrenza dei prodotti di importazione è tale da ridurre considerevolmente le vendite di queste aziende: le camicie cinesi costano un decimo delle italiane ed hanno qualità accettabile, l’olio d’oliva nordafricano, opportunamente corretto, esercita una concorrenza di prezzo insostenibile per i produttori olivicoli italiani. Questi prodotti si sono impadroniti della fascia medio-bassa del mercato e i nostri produttori non hanno mezzi per contrastarli. Una guerra di prezzo è insostenibile, bisogna puntare alla valorizzazione della qualità.
Ma il mercato locale non è in grado, da solo, di assorbire tutta questa produzione di qualità a prezzi così alti: è quindi necessario associare la qualità alla tipicità locale e aprirsi al mercato globale. La tipicità locale, infatti, è l’unica cosa che:
- non è copiabile dai paesi in via di sviluppo: un paio di scarpe “made in Italy” è “made in Italy” e basta, così come la ciliegia di Turi, i manufatti di Capodimonte o la cipolla di Tropea
- non è copiabile dalle aziende delle aree forti: gli investimenti in tecnologia, per quanto ingenti, non consentono di ottenere un prodotto di tipo artigianale.
Ma come può una piccola azienda locale aprirsi al mercato globale? Fino alla fine degli anni ’90 era molto complesso. Vendere direttamente all’estero era impossibile, trovare un intermediario era difficile salvo che non vi fosse una conoscenza diretta nel territorio di riferimento (il classico esempio del piccolo produttore con un parente emigrato in Germania).
La svolta è rappresentata dalla nascita e dalla affermazione di Internet: attraverso Internet, è possibile farsi conoscere nel mercato estero con investimenti minimi ed è possibile, ancora prima, conoscere i mercati e individuare quello obiettivo, trovare facilmente intermediari o clienti business. E, viste le dimensioni della nostra azienda, basterebbe trovare pochi clienti business in due o tre mercati di sbocco per garantire la sopravvivenza della nostra impresa.
In definitiva il ragionamento è semplice:
- il nostro prodotto è diventato di fascia medio-alta
- nel mercato locale non esiste una fascia medio-alta così grande da assorbire la nostra sia pur limitata produzione
- grazie ad Internet possiamo rivolgerci al mercato globale nel quale ci sarà sempre domanda di fascia medio-alta sufficiente ad assorbire la nostra offerta.
Su questo aspetto, peraltro, l’Italia ha un grosso vantaggio: la provenienza italiana è considerata sempre più indice di elevata qualità, i prodotti italiani sono sempre più richiesti all’estero e la sensibilità al prezzo di fronte ai prodotti ad elevata tipicità locale provenienti dal nostro paese cala notevolmente. E questo è un patrimonio da non disperdere, nonostante l’inadeguatezza delle legislazioni italiana e comunitaria.