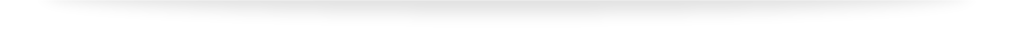Il giudice chiamato a pronunciarsi sulla congruità della retribuzione del lavoratore può fare riferimento ai CCNL ma il criterio principale per stabilire il giusta stipendio è rappresentato dall’articolo 36 della Costituzione: se l’applicazione di un contratto non la rispetta, non è legittimamente garantito il salario minimo.
Lo stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione (27711/ 2023) relativa al caso di un lavoratore a cui erano stati applicati, nell’ambito dello stesso appalto, diversi contratti per svolgere sempre le stesse mansioni ma con una diminuzione progressiva del corrispettivo.
Retribuzione congrua oltre il salario minimo
La Cassazione evidenzia che il giudice chiamato a verificare il rispetto dell’articolo 36 della Costituzione può sì fare riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi o nazionali (CCNL) di categoria (nel caso di specie, quelli delle cooperative) ma senza che questo significgi integrare altre valutazioni, per esempio considerando le soglie di povertà stabilite annualmente dall’Istat.
La nostra Costituzione, si legge nella sentenza, ha accolto «una nozione di remunerazione della prestazione di lavoro non come prezzo di mercato, ma come retribuzione sufficiente ossia adeguata ad assicurare un tenore di vita dignitoso».
Questa nozione non è «interamente rimessa all’autodeterminazione delle parti individuali né dei soggetti collettivi». In base all’articolo 36 della Costituzione:
il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
I requisiti per una remunerazione adeguata
I due requisiti di sufficienza e proporzionalità, recita la sentenza, «costituiscono limiti all’autonomia negoziale anche collettiva».
Pur «con tutta la prudenza con cui bisogna approcciare la materia retributiva ed il rispetto della riserva di competenza attribuita normalmente alla autorità salariale massima, rappresentata dalla contrattazione collettiva, non può che ribadirsi perciò come i criteri di sufficienza e proporzionalità stabiliti nella Costituzione siano gerarchicamente sovraordinati alla legge e alla stessa contrattazione collettiva ed abbiano contenuti (anche attinenti alla dignità della persona) che preesistono e si impongono dall’estreno nella determinazione del salario».
In altri termini «anche i salari dettati dalla contrattazione collettiva applicabile alle cooperative, secondo la legge n. 142/2001 e la legge n. 31/2008, possono essere disapplicati dal giudice ed il trattamento retributivo annullato e sostituito con uno più congruo, che rispetti il minimo costituzionale».
Il riferimento alle cooperative è determinato dal caso specifico in esame. Ma in generale, prosegue al sentenza, «la necessità di una verifica giudiziale “nonostante” la contrattazione, per individuare nel caso concreto un minimo invalicabile in attuazione della regola costituzionale, si pone dunque in ogni caso».
Legge sul salario minimo: riferirsi contrattazione non basta
La sentenza pone in evidenza anche i limiti dell’attuale frammentazione contrattuale, che rende spesso difficile fare riferimento a un contratto collettivo di riferimento. Inoltre, contiene una considerazione su un’eventuale legge sul salario minimo che richiami esclusivamente la contrattazione collettiva.
«L’aporia tra il trattamento retributivo previsto nella contrattazione collettiva e i contenuti precettivi dell’articolo 36 della Costituzione», rileva l’Alta Corte, può «prodursi anche per il tramite di una legge che rinvii alla contrattazione», e tale contraddizione non è «del tutto idonea ad essere risolta con il solo sostegno alla contrattazione nazionale maggiormente rappresentativa (come ad es. nella legge 142/2001 e nella 1. n.31/2008), non potendosi mai escludere che il trattamento retributivo erogato in forza della stessa possa attestarsi nel caso concreto al di sotto del minimo costituzionale».