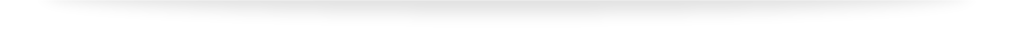Per il diritto ai premi di produttività, la legge prevede che ci debba essere un incremento di produttività, misurabile attraverso specifici criteri: un requisito, quello dell’incrementalità, che viene contestato dai Consulenti del Lavoro che lo ritengono contrario allo spirito che ha ispirato il Patto per il Lavoro del 1993 e la contrattazione di secondo livello. Le ragioni di tale posizione critica sono contenute nell‘approfondimento del 3 dicembre 2018 della Fondazione Studi.
=> Poco welfare aziendale, meglio i premi di risultato
Premi produttività: normativa
Il ragionamento parte dall’analisi della norma, contenuta nei commi da 182 a 189 della legge 205/2015 sulla tassazione agevolata al 10% dei premi di produttività. In base alla quale, appunto, per l’erogazione del premio, che può raggiungere al massimo i 3mila euro ed è rivolto a lavoratori dipendenti con stipendio fino a 80mila euro, deve essere legata a «incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti» da apposito decreto ministeriale. La circolare 78/E dell’Agenzia delle Entrate aggiunge che deve essere raggiunto un obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello e che «il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio». In parole semplici, l’incremento di produttività è un presupposto necessario all’applicazione del regime agevolato. Ci devono anche essere contratti aziendali o territoriali di riferimento, che stabiliscano criteri di misurazione e verifica rispetto ad un periodo congruo.
Premi produttività: criticità
I Consulenti del Lavoro segnalano:
Il presupposto dell’incremento rispetto ad un periodo storico per la fruizione dell’agevolazione, non può essere condiviso per una serie di ragioni eterogenee.
Innanzitutto, viene osservato che:
Il regime agevolato ha trovato i propri precedenti genetici nel Patto sul Lavoro del 1993, che ha potenziato il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nel determinare la regolamentazione del lavoro, anche per motivi di carattere politico-economico.
Uno dei maggiori elementi di innovazione del Patto del Lavoro del ’93 è stato rappresentato proprio dalla contrattazione di secondo livello. In base a questa innovazione, al contratto collettivo nazionale di lavoro è demandato l’obbligo di adeguare le retribuzioni alla perdita del potere di acquisto, mentre:
Al contratto di secondo livello è attribuita la funzione di incentivare le retribuzioni sulla base dei risultati aziendali, evitando una degenerata crescita “indipendente” dei salari e, conseguentemente, effetti negativi sotto il profilo inflazionistico».
Tecnicamente, è la concertazione, che ha imposto agli stessi sindacati «un salto di qualità culturale». La contrattazione di secondo livello rappresenta il presupposto per il superamento della «vecchia logica della conflittualità sindacale attraverso strumenti razionali di dialettica negoziale, volti a corroborare la performance aziendale con sistemi premiali di incentivazione dei lavoratori, favorendo la competitività di sistema: da una parte la competitività interaziendale interna, dall’altra la competitività esterna tra l’Italia e gli altri paesi». Sulla base di questo presupposti, i consulenti del Lavoro ritengono che la retribuzione variabile non possa «non essere differenziata, a seconda dei momenti storici, sotto il profilo economico e in ragione delle condizioni aziendali».
Non a caso, dagli anni 90 in poi, la contrattazione collettiva ha sempre individuato obiettivi negoziati, quasi mai basati su dati storici. Opzione che:
Determinerebbe, da una parte, la ricerca di un miglioramento costante che, estremizzando il concetto, oltre certi limiti sarebbe irraggiungibile. Dall’altra, stresserebbe i lavoratori in maniera non accettabile per la continua ricerca della performance. Senza considerare che, in momenti di carattere congiunturale, sarebbe pressoché impossibile raggiungere determinati obiettivi per una naturale e imprescindibile involuzione aziendale.
Quindi, «la misurazione dell’obiettivo in termini incrementali rispetto ad un determinato dato storico» rappresenta «una distorsione nella stessa determinazione del risultato». Fra l’altro, il decreto ministeriale che fissa i criteri per il premio di produttività, stabilisce che gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, possono consistere:
Nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
Quindi, non solo indicatori numerici. E il concetto di periodo congruo, va riferito non alla comparazione rispetto a un periodo precedente in termini di performance, ma al periodo all’interno del quale si consegue il risultato. «Una diversa interpretazione – concludono i Consulenti del Lavoro -, riscontrerebbe peraltro un significato illogico se è vero che, soprattutto in un periodo di criticità economiche, i lavoratori sono costretti a porre in essere uno sforzo maggiore per consentire alla propria azienda di risollevarsi, non ricevendo alcun premio agevolabile per effetto della richiamata comparazione».