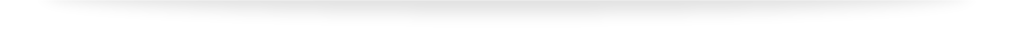L’importo dell’indennità di risarcimento per il licenziamento illegittimo non può essere deciso in base ai criteri previsti dal Jobs Act (articolo 3 del dlgs 23/2015): lo stabilisce la Corte Costituzionale, secondo cui (sentenza n. 194 depositata l’8 novembre) la norma in questione non consente di considerare:
parametri diversi dall’anzianità di servizio, e la rende uniforme per tutti i lavoratori con la stessa anzianità.
Secondo il Jobs Act prima ed il Decreto Dignità poi, al lavoratore che subito un licenziamento illegittimo, spetta un’indennità pari a due mensilità per ogni anno di servizio, da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità. In pratica, l’indennità assume i connotati di una «liquidazione legale forfettizzata e standardizzata, proprio perché ancorata all’unico parametro dell’anzianità di servizio, a fronte del danno derivante al lavoratore dall’illegittima estromissione dal posto di lavoro a tempo indeterminato».
L’articolo 3, comma 1 – diversamente dall’articolo 18 dello statuto dei lavoratori – non definisce l’indennità «onnicomprensiva», ma, nonostante questo, «è in effetti palese la volontà del legislatore di predeterminare compiutamente le conseguenze del licenziamento illegittimo, in conformità al principio e criterio direttivo dettato dalla legge di delegazione di prevedere un indennizzo economico certo». Tuttavia, il fatto che la norma fissi per legge i tetti, rende il risarcimento del danno non incrementabile, pur volendone fornire la relativa prova.
Ci sono poi contestazioni specifiche su diversi punti della norma. La parte in cui determina l’indennità in un «importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio», secondo la Corte «contrasta, anzitutto, con il principio di eguaglianza, sotto il profilo dell’ingiustificata omologazione di situazioni diverse», perché nel prestabilire «interamente il quantum in relazione all’unico parametro dell’anzianità di servizio, la citata previsione connota l’indennità, oltre che come rigida, come uniforme per tutti i lavoratori con la stessa anzianità». Mentre invece «è un dato di comune esperienza, ampiamente comprovato dalla casistica giurisprudenziale, che il pregiudizio prodotto, nei vari casi, dal licenziamento ingiustificato dipende da una pluralità di fattori. L’anzianità nel lavoro, certamente rilevante, è dunque solo uno dei tanti».
Lo stesso legislatore, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015, «ha ripetutamente percorso la strada che conduce all’individuazione di tali molteplici fattori». Ad esempio, l’articolo 8 della legge 604/1966 (come sostituito dall’articolo 2, comma 3, della legge 108 del 1990), lascia discrezionalità al giudice, sia pure all’interno di un tetto minimo e di uno massimo, avendo riguardo per:
numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’impresa, anzianità di servizio del prestatore di lavoro, comportamento e condizioni delle parti.
Un altro riferimento legislativo è l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, in base al quale l’indennità risarcitoria è determinata dal giudice tra un minimo e un massimo di mensilità, seguendo criteri in larga parte analoghi a quelli indicati in precedenza,
avuto riguardo anche alle dimensioni dell’attività economica.
Quindi, fino al Jobs Act il legislatore aveva «sempre valorizzato la molteplicità dei fattori che incidono sull’entità del pregiudizio causato dall’ingiustificato licenziamento e conseguentemente sulla misura del risarcimento», discostandosi poi da questo percorso con la legge del 2015. La Corte sottolinea che «in una vicenda che coinvolge la persona del lavoratore nel momento traumatico della sua espulsione dal lavoro, la tutela risarcitoria non può essere ancorata all’unico parametro dell’anzianità di servizio. Non possono che essere molteplici i criteri da offrire alla prudente discrezionale valutazione del giudice chiamato a dirimere la controversia. Tale discrezionalità si esercita, comunque, entro confini tracciati dal legislatore per garantire una calibrata modulazione del risarcimento dovuto, entro una soglia minima e una massima».
Quindi, «all’interno di un sistema equilibrato di tutele, bilanciato con i valori dell’impresa, la discrezionalità del giudice risponde all’esigenza di personalizzazione del danno subito dal lavoratore, pure essa imposta dal principio di eguaglianza», mentre «una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, si traduce in un’indebita omologazione di situazioni che possono essere – e sono, nell’esperienza concreta – diverse».
La forfettizzazione pari a due mensilità per ogni annualità di servizio appare anche, secondo la Corte, non rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza e adeguatezza. In definitiva, la legge «prevede una tutela economica che non costituisce né un adeguato ristoro del danno prodotto, nei vari casi, dal licenziamento, né un’adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente», rappresentando quindi un vulnus anche rispetto al «diritto al lavoro» (articolo 4, primo comma, della Costituzione) e alla «tutela» del lavoro «in tutte le sue forme ed applicazioni» (articolo 35, primo comma, della Costituzione), che «comportano la garanzia dell’esercizio nei luoghi di lavoro di altri diritti fondamentali costituzionalmente garantiti». Risultato: l’articolo 3 del dlgs 23/2015 è incostituzionale.