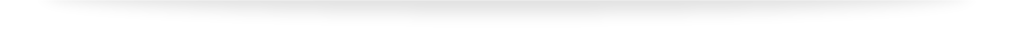Un lavoratore che segnala illeciti senza rispettare le procedure previste dalle regole sul whistleblowing può essere legittimamente licenziato. In merito, si è recentemente pronunciata la Cassazione la quale, con la sentenza 17715/2024.
La Corte ha richiamato un precedente orientamento per cui la normativa sul whistleblowing tutela il dipendente da sanzioni o reazioni ritorsive dirette ed indirette conseguenti alla sua denuncia, ma non istituisce un esimente per eventuali illeciti che egli, da solo o in concorso con altri responsabili, abbia commesso, potendosi al più valutare il ravvedimento operoso o la collaborazione al fine di consentire gli opportuni accertamenti sulla proporzionalità della sanzione da irrogare.
Ma andiamo con ordine.
I fatti al centro del caso sul whistleblowing
La vicenda muove dal licenziamento per giusta causa di una dipendente la quale aveva inoltrato, a vari destinatari (ed anche, da quel che si legge, estranei, ai relativi reparti di competenza dell’ente datore di
lavoro) il modello per la segnalazione di condotte illecite (c.d. whistleblower), tramite cui la ricorrente aveva denunciato la sottrazione da parte dell’allora Direttore di Roma 1 di fondi pubblici del MIUR in relazione al progetto premiale, per periodo il 2012-2018, “Studio di preparazione dei forti terremoti” destinati per la parte geochimica alla stessa – dipendente – nonché il plagio, il danno intellettuale, finanziario, di carriera, di immagine e a danno di terzi.
A seguito delle relative valutazioni, l’Ente aveva concluso che la segnalazione della dipendente «non poteva essere considerata come rientrante nelle tutele di cui all’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 in quanto non era stata trasmessa con le modalità previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020 e che, in ogni caso, dalla relazione del responsabile anticorruzione non era emersa alcuna anomalia nella
gestione delle vicende segnalate».
A fronte di tale esito, l’Ente ha dunque contestato alla dipendente di aver utilizzato impropriamente il canale di whistleblowing, «riportando circostanze risultate non vere che avevano diffamato e nociuto all’onore e
alla reputazione dell’allora direttore di Roma 1».
Oggetto di contestazione era stata anche altra vicenda e cioè il nocumento procurato a un professore universitario facente parte dell’Ente datore di lavoro e avvicinato «nei locali dell’ente dalla ricorrente, la quale aveva registrato la conversazione avuta col medesimo e poi pubblicato i riferimenti della conversazione sul proprio profilo Facebook in modo travisato e stravolto».
A fronte di tali condotte contestate, l’Ente ha licenziato la dipendente per giusta causa.
I giudizi di merito
La Corte d’appello, in conferma della decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto dalla dipendente e volto ad accertare l’illegittimità del licenziamento per giusta causa. La Corte territoriale ha ritenuto preliminare ed assorbente, in relazione alla valutazione di legittimità sul licenziamento irrogato alla dipendente «la gravità del comportamento di quest’ultima relativo alla registrazione della conversazione avvenuta tra la medesima e il professore, successivamente pubblicata su Facebook».
Nello specifico, il fatto di aver registrato di nascosto il professore e di aver pubblicato stralci della conversazione – «peraltro non autorizzati e prospettati in maniera capziosa» sì da «seminare sospetti e da comportare discredito all’Ente – su di un social network» (profilo Facebook personale della dipendente) ha costituito, a parer della Corte, una «grandissima violazione delle norme che regolano il rapporto di lavoro».
In particolare gli artt. 3 e 13 del codice di comportamento dell’Ente (compromissione dell’immagine dell’Ente e violazione dell’obbligo di tenere condotte tali da favorire un clima di rispetto reciproco e di evitare ogni comportamento molesto e lesivo della dignità della persona) e gli artt. 11 e 13 del CCNL di categoria (violazione dell’obbligo di tenere una condotta corretta e del divieto di astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona, con intenzionalità del comportamento).
In conclusione, la medesima Corte ha affermato «la sussistenza dei presupposti del licenziamento per giusta causa, alla luce dell’accertata irrimediabile lesione del rapporto fiduciario specie considerando che la
ricorrente era dirigente e quindi si trovava in una situazione di particolare responsabilità nei confronti del personale preposto, dei suoi collaboratori e in generale per il grado di affidamento e fiducia riposto da
parte datoriale nei suoi confronti».
Ad abundantiam, la Corte territoriale non si è limitata nelle proprie valutazioni ed ha ritenuto fondati anche gli altri addebiti disciplinari con i quali veniva contestato alla dipendente di aver utilizzato impropriamente il whistleblowing, rilevando altresì che la predetta aveva fatto un uso improprio per il quale non aveva neppure seguito la procedura prevista ai fini dell’applicabilità dell’articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (l’invio della segnalazione era stato fatto senza garantire la segretezza della stessa e dello stesso nominativo della segnalante) e ritenendo precisamente che l’intento della segnalazione non sembrava quello di agire a tutela della PA e per il suo interesse (che altrimenti ella avrebbe seguito la procedura prevista, che garantisce l’anonimato e consente alla p.a. di effettuare i dovuti accertamenti), bensì, in ultima analisi, quello di portare nei luoghi di lavoro discredito al collega».
La sentenza della Corte di Cassazione
A fronte di tali giudizi, la dipendente ha dunque adito la Corte di Cassazione con ricorso cui ha resistito l’Ente datore di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della dipendente ed ha confermato, condividendone anche le valutazioni, i precedenti gradi di giudizio.
A parer della Cassazione, la registrazione della conversazione con il professore (avvenuta all’insaputa di quest’ultimo) e pubblicata sui social non poteva assumere la valenza di una «scriminante difensiva al fine di tutelare la propria posizione in azienda e di precostituirsi mezzi di prova nelle sedi processuali» (la Corte territoriale aveva evidenziato come le difese della lavoratrice fossero erano del tutto prive dell’indicazione della necessità difensiva).
Dunque, se è vero che una registrazione di conversazioni tra un dipendente e i suoi colleghi presenti (all’insaputa dei conversanti) non sia in assoluto abusiva e illegittima, in quanto può rientrare nell’ambito
della protezione fornita dall’art. 54-bis D.Lgs. n. 165 del 2001, è anche vero che al fine di attivare tale «meccanismo di protezione» occorre vi sia un’effettiva necessità difensiva.
Precisamente, occorre che, ad esempio, la registrazione della conversazione (carpita di nascosto) sia pertinente ad una difesa incentrata su un intento di rappresaglia per effetto della segnalazione ed il mezzo utilizzato non ecceda l’esercizio di tale diritto di difesa.
Ne deriva che la scriminate di cui all’art. 54-bis cit. non può considerarsi estendibile fino a ricomprendere ogni ipotesi in cui i lavoratori che effettuino indagini di propria iniziativa e violino la legge per raccogliere prove di illeciti nell’ambiente di lavoro. La medesima, invece, dovrà considerarsi operativa solo nei confronti di chi segnala notizie di un’attività illecita senza che sia ipotizzabile una tacita autorizzazione a improprie e illecite azioni di indagine.
La Corte di Cassazione ha affermato dunque che «il giudice di secondo grado, rifacendosi a recenti orientamenti di questa Corte, ha ritenuto legittimo il licenziamento per il suddetto comportamento tenuto
dalla dipendente, escludendo ogni collegamento causale tra lo stesso e la segnalazione ai sensi dell’articolo 54-bis».
E ha definito corretto il ragionamento, in nome del seguente principio, richiamato dalla sentenza 9148/2023: «la normativa di tutela del dipendente che segnali illeciti altrui (c.d. whistleblowing) salvaguarda il medesimo dalle sanzioni che potrebbero conseguire a suo carico secondo le norme disciplinari o da azioni ritorsive dirette ed indirette conseguenti alla sua denuncia, ma non istituisce un esimente per gli autonomi illeciti che egli, da solo o in concorso con altri responsabili, abbia commesso, potendosi al più valutare il ravvedimento operoso o la collaborazione al fine di consentire gli opportuni accertamenti nel contesto dell’apprezzamento, sotto il profilo soggettivo, della proporzionalità della sanzione da irrogarsi nei confronti del medesimo».
di Davide Maria Testa, avvocato c/o DLA Piper – esperto in Diritto del Lavoro, Relazioni Industriali e Riorganizzazioni aziendali