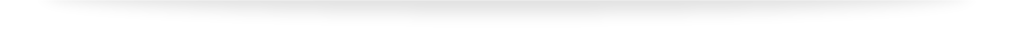Più Europa, più innovazione, più lavoro, più impresa: con una estrema semplificazione, si potrebbe riassumere con questo slogan la ricetta proposta dal Governatore dell Banca d’Italia, Ignazio Visco, in occasione delle Considerazioni finali 2019. Un discorso, quello del banchiere centrale italiano, che in realtà insiste particolarmente su uno dei punti sopra esposti, l’Europa, partendo dall’analisi storica dei primi 20 anni di euro per arrivare alla valutazione dell’attuale congiuntura e delle prospettive di crescita.
=> Manifattura digitale e PMI, traino dell'industria italiana
Crescita: analisi storica
Il punto fondamentale è il seguente: «La debolezza della crescita dell’Italia negli ultimi vent’anni non è dipesa né dall’Unione europea né dall’euro; quasi tutti gli altri Stati membri hanno fatto meglio di noi. Quelli che oggi sono talvolta percepiti come costi dell’appartenenza all’area dell’euro sono, in realtà, il frutto del ritardo con cui il Paese ha reagito al cambiamento tecnologico e all’apertura dei mercati a livello globale».
Attenzione: è anche vero che, sebbene la moneta unica «abbia rappresentato un passo cruciale nel processo di integrazione europea, l’Unione economica e monetaria rimane una costruzione incompiuta». Chi ha disegnato l’architettura della moneta unica confidava in passaggi successivi che, invece, non si sono (per ora) compiuti. «Ancora prima dell’introduzione dell’euro erano state sottolineate la peculiare condizione di una moneta senza Stato, la solitudine istituzionale della BCE, i problemi posti dalla mobilità imperfetta del lavoro e dei capitali». L’inadeguatezza della governance europea è pienamente emersa negli anni della crisi del debito. Dunque, bisogna fare passi avanti e in questo percorso l’Italia può e deve avere un ruolo da protagonista: «l’Italia ha la responsabilità di contribuire a sbloccare la situazione e le capacità per partecipare in maniera costruttiva alla definizione dei passaggi necessari a completare l’Unione economica e monetaria». Ma deve anche fare i conti con debolezze strutturali interne.
=> PMI traino del Paese: ecco le sfide chiave
Il Paese negli anni scorsi ha scontato un’eccessiva esposizione alla concorrenza delle economie emergenti, determinata anche dal «ritardo con cui ha risposto ai cambiamenti imposti dal progresso tecnologico e dall’apertura dei mercati globali», e il fatto di non aver «completato il percorso di risanamento dei conti pubblici avviato negli anni Novanta, accollandosi i rischi connessi con un’elevata dipendenza dai mercati finanziari per il rifinanziamento del debito pubblico». Risultato: «un Paese dove la produttività già ristagnava ha dovuto sopportare le conseguenze di una crisi finanziaria globale avviata in un altro continente e di una crisi dei debiti sovrani che non aveva contribuito a innescare» e «la sofferenza economica e sociale è stata amplificata dalle difficoltà, effettive e percepite, incontrate nella gestione di flussi migratori crescenti».
Crescita: lo stato attuale
E ora, l’Italia fatica ancora «a riprendersi dalla doppia recessione, «perché paga il prezzo di un contesto che – per qualità dei servizi pubblici e rispetto delle regole – è poco favorevole all’attività imprenditoriale». I problemi fondamentali: ritardo tecnologico grave, frutto di una struttura produttiva frammentata e sbilanciata verso aziende che trovano difficoltà a crescere e a innovare. Distorsioni prodotte dall’evasione fiscale e dal debito pubblico, «che rende più costosi i finanziamenti per le famiglie, per le imprese e per le banche, oltre che per lo stesso Stato». Condizioni di costante incertezza che comprimono investimenti delle imprese, consumi delle famiglie, lavoro, e aumentano il disagio sociale.
Il rischio di «un netto indebolimento della capacità produttiva del Paese e la prospettiva di una forte pressione sulle finanze pubbliche» esiste. Sono diversi i passaggi in cui Visco sottolinea la persistenza di un clima poco favorevole allo sviluppo delle imprese, alla crescita, al lavoro. E attenzione: «limitarsi alla ricerca di un sollievo congiunturale mediante l’aumento del disavanzo pubblico può rivelarsi poco efficace, addirittura controproducente qualora determini un peggioramento delle condizioni finanziarie e della fiducia delle famiglie e delle imprese». Visco non sottovaluta il rischio di una «espansione restrittiva», nel senso che «l’effetto espansivo di una manovra di bilancio può essere più che compensato da quello restrittivo legato all’aumento del costo dei finanziamenti per lo Stato e per l’economia». In termini molto semplici: lo stimolo alla crescita deve andare di pari passo con il miglioramento dei conti pubblici.
Crescita: la ricetta di Visco
Molto in sintesi, le ricette del Governatore:
- ampia riforma fiscale, da portare avanti non rivedendo di volta in volta alcune agevolazioni ma con un intervento ch disegni una «struttura stabile che dia certezze a chi produce e consuma, investe e risparmia, con un intervento volto a premiare il lavoro e favorire l’attività di impresa»;
- aumenti decisi nella partecipazione al lavoro e nella produttività: pur salito negli ultimi venti anni dal 61 al 66 per cento, il tasso di partecipazione al lavoro è oggi ancora inferiore di 8 punti percentuali alla media europea. La partecipazione femminile è aumentata, dal 47 al 56%, ma l’incremento è «inferiore a quello registrato nel resto dell’Unione europea e il tasso di attività degli uomini è ancora superiore di 19 punti a quello delle donne, uno dei divari più elevati in Europa»;
- l’immigrazione può dare un contributo alla capacità produttiva del paese: vanno affrontate le difficoltà che incontriamo nell’attirare lavoratori a elevata qualificazione così come nell’integrazione e nella formazione di chi proviene da altri paesi;
- rientro dei cervelli: l’emigrazione dei giovani ha raggiunto lo 0,5 per cento nel 2017, quintuplicandosi nell’arco di dieci anni; quella dei laureati, pari allo 0,4 per cento, è raddoppiata;
- digitalizzazione, tecnologia, innovazione: capitolo fondamentale, qui l’Iralia continua a scontare forti ritardi. «Ai settori che compongono l’economia digitale è oggi riconducibile il 5 per cento del totale del valore aggiunto, contro circa l’8 in Germania e una media del 6,6 nell’Unione europea. Siamo in ritardo sull’automazione della produzione, nello sviluppo di reti tlc, sulla digitalizzazione della pa e dei servizi pubblici digitali;
- Mezzogiorno: qui ci sono parecchi ritardi (infrastrutture, adozione tecnologie, efficienza della PA, legalità).
Conclusione: «Va favorito in tutti i modi l’aumento dei tassi di partecipazione al mercato del lavoro, prolungando l’attività in linea con l’aumento dell’aspettativa di vita ed eliminando gli ostacoli al lavoro femminile». Vanno svolte adeguate politiche per il Mezzogiorno e per la crescita. Ma, lo sottolineiamo, c’è anche un richiamo al mondo imprenditoriale:
Sta alle imprese cogliere le occasioni che offrono il mercato e la tecnologia, essere pronte a crescere, anche aprendosi a contributi esterni di capacità e di capitale; a chi studia e lavora contribuire al cambiamento ricercando nuove e maggiori competenze.
Stesso discorso per banche e intermediari finanziari, che «dovranno essere in grado, nel loro stesso interesse, di appoggiare con prudenza, ma anche con sagacia, questo processo».