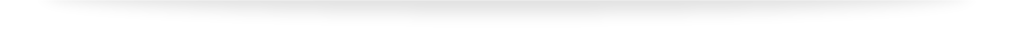C’è un’emergenza che svolazza sulla testa di tutti gli italiani. E che meriterebbe di essere affrontata al più presto, per evitare un (già assai probabile) salasso di fine anno. Si chiama aumento delle aliquote IVA. Nel Documento di Economia e Finanza (DEF) varato in data 26 aprile dal governo Gentiloni – quello in carica, d’altronde non si riesce a farne un altro – è previsto un pacchetto da incubo: l’IVA ridotta del 10% passerà nel 2019 all’11,5% e nel 2020 al 13% mentre quella ordinaria del 22% passerà dal 24,2% l’anno prossimo al 24,9% nel 2020 fino al 25% del 2021. Si salvi chi può.
Una sventagliata che potrebbe essere fatale per la già debole ripresa dei consumi e per la claudicante crescita economica – confermata dallo stesso, inutile Def a un “prudenziale” 1,5% per il 2018 – e colpirebbe praticamente ovunque: beni di prima necessità coperti dall’imposta agevolata (carne, pesce, riso, uova, miele, zucchero, yogurt) così come vino o birra (attualmente al 22%) solo per rimanere all’alimentare, che è il primo fronte a cui si guarda. Come ha ricordato Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio:
“Abbiamo sempre evidenziato come l’aumento delle aliquote IVA, che comporterebbe 12,4 miliardi di imposte aggiuntive, distruggerebbe qualsiasi ipotesi di crescita è dunque molto importante che anche il ministro Padoan abbia ribadito la necessità di scongiurare questa eventualità che, per il nostro Paese, significherebbe dire addio alla ripresa”.
In effetti, il responsabile dell’Economia, pur nel contesto di un documento che di programmatico non ha – e d’altronde non può avere – nulla di politico al suo interno, si è concentrato su quell’unico, nefasto fronte. Che colpirebbe ancora di più i consumi tenendo l’inflazione (a marzo +0,8 su anno, +0,3% su mese) davvero troppo bassa.
Come ha spiegato Padoan, le clausole di salvaguardia che comporterebbero l’aumento dell’IVA:
“sono tenute dentro nell’aspettativa che, come in passato, il prossimo governo presenti misure per rimuoverle”.
Come si legge nella nota di accompagnamento al Documento:
Il DEF approvato oggi si limita alla descrizione dell’evoluzione economico-finanziaria internazionale, all’aggiornamento delle previsioni macroeconomiche per l’Italia e del quadro di finanza pubblica tendenziale che ne consegue. Spetterà al nuovo esecutivo la scelta delle politiche che determineranno il nuovo quadro programmatico.
Dunque non i dazi commerciali, gli equilibri internazionali e ancor meno le caselle dei ministri o i nomi dei presidenti del Consiglio preoccupano gli italiani. La priorità sulla scrivania del prossimo inquilino di palazzo Chigi sarà, come ormai capita dall’epoca del governo Monti, la caccia al tesoretto d’autunno.
Di soldini ne serviranno tanti: 12,4 miliardi, come si spiegava, per il 2019 e ancora 19,1 per il 2020. Numeri che abbiamo appena inviato a Bruxelles per una prima analisi della direzione dei conti pubblici e che andranno necessariamente rivisti con l’aggiornamento di settembre, vero calcio d’inizio dell’assalto alla diligenza della legge di bilancio.
Sono cifre sulle quali, per altro, tutti i partiti impegnati nelle estenuanti consultazioni, esplorazioni e trattative non sembrano al momento badare neanche per sbaglio. Eppure, fossimo nei leader in pectore, ci preoccuperemmo non poco e lo spiegheremmo per filo e per segno agli italiani che un buon 50% delle risorse da mobilitare con la vecchia finanziaria non potranno che finire in quell’operazione. Notizia positiva da un lato, per tutto ciò che abbiamo spiegato finora, ma che ormai da troppo tempo affossa ogni politica espansiva riducendo la legge di bilancio a un provvedimento povero di stimoli e investimenti e ricco di tagli e coperte sempre più corte.
Fra l’altro, sullo sfondo aleggia la quasi certezza che dalla Commissione UE arrivi a stretto giro la richiesta di una manovrina, da mettere in cantiere già fra maggio e giugno, che ruoti intorno ai 3-4 miliardi di euro. Destinata stavolta ai pasticci sul rapporto deficit/Pil e sul debito pubblico crescente. Ma nel DEF del terminale (davvero?) esecutivo Gentiloni non c’è traccia di una marcia in quella direzione né appunto verso la neutralizzazione degli aumenti. E se le forze politiche sono ovviamente concordi sulla necessità assoluta di questa mossa, la realtà dice che né i balletti su e giù dal Colle né le posizioni esplicite (fateci caso, programmi e temi sono completamente scomparsi da tre mesi, si parla per frasette sempre più scheletriche) hanno ben chiara questa emergenza.
Come e dove trovare le coperture? Difficile dirlo, se non affidandosi alle solite speranze della “spending review”. Si tratta di uno stillicidio contro cui combattiamo ormai dal 2011. E su cui non sarebbe stato male muoversi fin dalla primavera, proprio come aveva fatto Gentiloni l’anno scorso con un provvedimento da 3,8 miliardi che ha sforbiciato l’importo previsto per alcuni mesi dopo, abbassando a 15,7 miliardi i fondi necessari e poi, con altre mosse, a 14,9 miliardi.
Basta fare un po’ di storia del decreto legge 138/2011 varato nell’estate di quell’anno dal governo Berlusconi per rispondere alla crisi finanziaria che soffiava sui conti (e sugli squilibri) del Paese, per rendersi conto che nessuno ha mai trovato il modo di uscirne. L’ex cav. portò l’Iva dal 20 al 21%. Quando Mario Monti ne prese il posto a palazzo Chigi, pochi mesi dopo, introdusse col Salva Italia un aumento ulteriore di 2 punti: a partire da ottobre 2012 da 10 a 12 l’aliquota ridotta e da 21 al 23 l’ordinaria con un ulteriore salto di 0,5 punti dal 2014 per arrivare a regime a 12,5 e 23,5%. Decisioni su cui si fece poi retromarcia col decreto sulla revisione della spesa dell’estate 2012, posticipando l’aumento di due punti delle due aliquote al primo luglio 2013.
La legge di stabilità di quell’anno dispose inoltre la sterilizzazione dell’incremento di un punto dell’Iva ordinaria e la completa sterilizzazione dell’aliquota ridotta. Il successivo governo Letta, progressivamente abbandonato in autunno dal Cavaliere che aveva deciso di sostenerlo in una prima fase, prima rinviò di tre mesi e poi cedette, alzando l’Iva al 22%, livello attuale. Dal 2014, col governo Renzi, è stata tutta una gara a disinnescare le clausole (e a occuparsi di agevolazioni, detrazioni e accise): nel 2015 il gioco ci è costato circa 13 miliardi, 15,3 nel 2016.