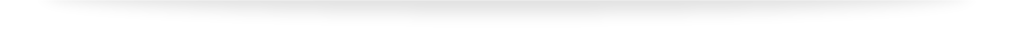La contrastata riforma del lavoro, nelle intenzioni del Governo Monti, dovrebbe ridare slancio e competitività al Paese e per farlo ha scelto di passare sopra anche all’articolo 18: la domanda che ora tutti si pongono è una e una sola: ora che è stato squarciato quel velo di “protezionismo lavorativo” che ha condizionato l’Italia negli ultimi decenni, il Paese tornerà davvero ad essere competitivo, o si tratta solo di una riforma a vantaggio di alcuni a scapito di altri (nello specifico lavoratori dipendenti e pensionati?)
La questione è complessa, e merita un approfondimento.
Innanzitutto c’è da dire che nel sistema economico attuale, piaccia o no, ad essere centrale non è il lavoratore ma l’impresa. Solo se le imprese producono e crescono è possibile mantenere il meccanismo produzione-consumo-produzione su cui si regge tutta la società occidentale nel senso allargato del termine.
E’ per questo motivo che i governi stanno cercando di mettere a punto misure che favoriscano l’imprenditoria, pur se questo dovesse costare un netto peggioramento delle condizioni di vita del lavoratore.
Nel caso specifico dell’Italia, la situazione lavorativa è stagnante da diversi anni. Insomma, non si fa molta impresa.
Inoltre c’è una netta sperequazione tra dipendenti tutelati (che godono di diritti, sindacati che li difendono e che sono illicenziabili) e neo-assunti che non godono di alcuna tutela.
L’azione del Governo mira da un lato a ridurre questa sperequazione, introducendo delle garanzie a vantaggio dei neo-assunti e dei precari, e dall’altro a rendere il mercato del lavoro più flessibile, consentendo alle imprese in difficoltà di licenziare per motivi economici dipendenti che, una volta creato un circolo virtuoso, in breve tempo potranno essere assunti da altre aziende.
In teoria, questi tipi di misure sono eccellenti, da manuale micro e macro-economico. Non a caso, sono prese dal Governo dei professori, un Governo che non dovrebbe avere preconcetti politici a favore di una fazione o di un’altra e che è composto per lo più, cosa rara per questo paese, da persone competenti. Nella pratica, tuttavia, quello che si sta realmente facendo per favorire un circolo produzione-consumo-produzione virtuoso è di fatto una operazione di marketing internazionale, consistente nell’esportare all’estero un’immagine di paese dove “diventa più facile licenziare”, considerando le tutele sociali un impedimento agli investimenti esteri che deve essere rimosso al più presto. Dal momento che non viviamo in Svezia, tuttavia, il prezzo di una riforma sulla carta corretta verrà pagato, con tutta probabilità , dalle categorie sociali più deboli.
In Italia, infatti, il mercato del lavoro non è flessibile. Una persona di 40 o 45 anni che perde il proprio lavoro, se non è un professionista di qualche settore particolare ma un semplice dipendente, difficilmente ne riesce a trovare uno nuovo. Peggio ancora per chi ha superato i 50, deve attendere 15 anni per la pensione e avrà solo due anni di stipendio pagato. La sensazione è che si stia mettendo in pratica una riforma giusta ma nel paese sbagliato. Gli economisti e i cattedratici di oggi, così come gli illuministi di allora, vanno avanti con le riforme, forti della coerenza con quanto scritto sui loro manuali, certi di essere nel giusto. Senza rendersi conto che, ramo dopo ramo, stanno tagliando l’albero sul quale sono essi stessi seduti. Farebbero i politici di meglio? Certamente no. Tuttavia la sicurezza con cui il Governo ostenta i benefici futuri della riforma del lavoro è così certa e incrollabile che, paradossalmente, qualche dubbio non può non nascere. Anche perché, se il risultato in termini di crescita è incerto, gli effetti sulle condizioni di lavoro non tarderanno a farsi sentire.