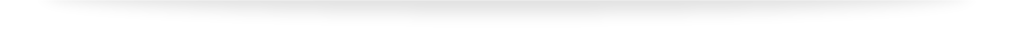La nascita della figura dirigenziale nell’ordinamento italiano, come qualifica dotata di propria autonomia rispetto alla categoria impiegatizia, viene fatta generalmente coincidere con l’emanazione del R.D. n.1130/1926, che all’art. 6 imponeva a tutti i «direttori tecnici ed amministrativi e gli altri capi di ufficio, di servizi con funzioni analoghe, gli estintori in generale e gli impiegati muniti di procura» di entrare a far parte di associazioni sindacali autonome rispetto a quelle degli altri lavoratori, «intellettuali e manuali».
Questa prima definizione legislativa resterà l’unica riguardante la categoria come a sé stante, avente la funzione, non di circoscrivere l’applicazione di una disciplina speciale, bensì di operare una distinzione dei dirigenti sia sul piano dell’organizzazione aziendale, sia su quello della contrattazione collettiva. Alla definizione dettata nel ’26, negli anni successivi, si accompagnò un’intensa elaborazione giurisprudenziale.
Si passò così dall’elencazione dei profili professionali tipici, contenuta nel citato decreto, all’analisi dei tratti distintivi che doveva possedere il manager nello svolgimento delle sue funzioni quale sostituto dell’imprenditore, cioè del dirigente inteso quale alter ego del capo dell’impresa.
Fu quindi elaborata una concezione gerarchica del manager e furono indicate le peculiarità che doveva possedere: ampia discrezionalità operativa, subordinazione diretta ed esclusiva all’imprenditore o all’organo amministrativo, subordinazione degli altri lavoratori nei suoi confronti, carattere spiccatamente fiduciario della collaborazione.
Si ritiene che tali indicazioni giurisprudenziali furono prese come spunto dal legislatore del ’42 con la menzione, restrittiva ed elitaria, nell’art. 2095 c.c. dei “dirigenti amministrativi o tecnici” (comma poi sostituito dalla legge 190/1985).
Con la caduta dell’ordinamento corporativo l’elaborazione giurisprudenziale portò a due tendenze contrapposte. Da un lato i giudici, dalla metà degli anni ’50, si mostrarono per lo più propensi ad un allargamento della categoria sia verso l’alto, accettando l’ammissibilità del cumulo tra carica dirigenziale e carica di amministratore della società, sia verso il basso, ammettendo il riconoscimento della qualifica a personale impiegatizio non dipendente direttamente dal vertice dell’impresa o non munito di ampio potere gerarchico in seno all’organizzazione aziendale (il c.d. low management).
Altra parte della giurisprudenza negò, invece, la concessione della qualifica al low management quando fosse mancato un accordo tra le parti, ossia quando la richiesta provenisse dal lavoratore ed il datore di lavoro vi si opponesse.
Contrapposizione non venuta meno neanche intorno agli anni ’70, quando la giurisprudenza pose al bando le c.d. “clausole di riconoscimento formale”, cioè le disposizioni dei contratti collettivi secondo cui l’attribuzione della qualifica dirigenziale doveva essere subordinata alla formale assegnazione di questo status da parte del datore di lavoro, a prescindere dalla effettiva assegnazione di poteri sostanziali.
In ogni caso, ancor oggi, pur in un ambito in cui la categoria dirigenziale si presenta “allargata” e le definizioni nei contratti collettivi si prestano ad interpretazioni estensive, molto difficilmente un giudice accoglierà la domanda di promozione su istanza del lavoratore, se non vi siano i requisiti fortemente selettivi delineati per la categoria fin dalle origini. A meno che l’allargamento non risulti in maniera chiara ed inequivocabile dal contratto collettivo.